
29 Giu Il senso di sicurezza nei bambini piccoli

La sicurezza
Uno degli elementi principali indispensabili per il sereno sviluppo psicoaffettivo del bambino è il vissuto soggettivo della sicurezza, tanto che le sue maggiori ansie derivano dalla perdita della sicurezza. Perdita che comporta ansie, paure e sfiducia in sé stesso e negli altri.
Per Militerni:
‹‹La sicurezza si riferisce a quel sentimento di stabilità emotiva derivante dalla maturazione di alcune certezze ‘interne’, che permettono al bambino di affrontare situazioni nuove e fronteggiare situazioni insolite››. [1]
Per Maté G.:
‹‹…il fattore principale per uno sviluppo del cervello sano è la sicurezza emotiva e il calore dell’ambiente in cui il bambino cresce. Tale sicurezza va ben oltre l’amore e le buone intenzioni dei genitori. Dipende infatti da una variabile meno controllabile: l’assenza di motivi di stress che possono compromettere il loro equilibrio psicologico. Un ambiente emotivo sereno e stabile nel corso dell’infanzia è essenziale per un adeguato sviluppo dei circuiti neurofisiologici dell’autoregolazione››.
Da che cosa nasce la sensazione della sicurezza?
Giacché fonte primaria della sicurezza per il bambino sono la propria madre ed il proprio padre, ma anche gli altri familiari con i quali si è stabilito un legame di attaccamento sicuro, elemento importante, che dà a lui serenità e tranquillità, è la costante presenza di queste figure nella sua casa e nella sua vita.
Poiché il piccolo essere umano si apre agli altri e al mondo, in maniera progressiva in base alla maturazione emotiva ed affettiva, seguendo una precisa gradualità, egli ha bisogno della presenza dei genitori in maniera molto diversa in base all’età.
Per tale motivo, sensazione di sicurezza viene vissuta dal piccolo quando, almeno fino ai tre-quattro anni, può trascorrere le sue giornate vicino ad almeno uno dei genitori, soprattutto vicino alla madre, nella sua casa, nella sua stanzetta, con accanto i suoi giocattoli. Da queste realtà affettive, rappresentate dai suoi genitori, dai luoghi e dagli oggetti e giocattoli consueti, il bambino si allontana gradualmente negli anni. Questo allontanamento progressivo è collegato alla sua maturità e serenità ed alla fiducia che egli ha acquisito nei confronti di sé stesso, dei genitori e delle persone più vicine a lui.

Di conseguenza, più il bambino ha vissuto da molto piccolo, serenamente e pienamente il suo rapporto con mamma e papà, con gli altri familiari e l’ambiente domestico, tanto più facilmente riuscirà poi a farne a meno. Quanto più, invece, il bambino ha vissuto male i primi anni della sua vita, per cui è rimasto psicologicamente immaturo, insicuro o con problematiche affettivo-relazionali, tanto più questo legame persisterà negli anni. In definitiva è la crescita affettiva ed è la sicurezza interiore del bambino che facilita e rende possibile l’autonomia e non viceversa!
Lo scopo dell’educazione nel bambino piccolo
La logica conseguenza di quanto abbiamo detto è che lo scopo dell’educazione non dovrebbe essere quello di allontanare il bambino, rendendolo autonomo il più rapidamente possibile, ma quello di dargli serenità, fiducia e sicurezza rendendolo psicologicamente ed emotivamente maturo, in modo tale che ad un’età maggiore possa fare a meno della presenza della mamma, del papà, della sua casa e del suo ambiente familiare.
La presenza materna e paterna
Per tali motivi è necessario che, in presenza di un bambino piccolo, i genitori, e soprattutto le madri, siano presenti, anche se non necessariamente sempre e in maniera continua, seguendo con gradualità, i bisogni legati alla crescita fisiologica del minore.

La gradualità
Qual è questa gradualità? Un bambino neonato ha bisogno quasi esclusivamente della sua mamma o del suo papà e a volte di entrambi quasi ventiquattro ore al giorno. Tuttavia, quando il bambino ha qualche mese i genitori potranno allontanarsi da lui durante il giorno, per poche ore, affidando il figlioletto ad una persona con cui si è già instaurato un importante, forte e intenso legame affettivo, come una nonna, un nonno o una zia.
Cause di scarsa sicurezza
Minore sicurezza e serenità il piccolo avverte quando è affidato a una tata, meno ancora se, chi ha cura di lui, è un’anonima baby-sitter ad ore, mentre sono assolutamente sconsigliabili, prima dei tre-quattro anni gli asili nido, le scuole dell’infanzia o altri tipi di istituzioni, poiché soltanto verso questa età, egli accetterà fisiologicamente e senza traumi, di abbandonare per poche ore il nido familiare.
L’età per affrontare con sicurezza ambienti e persone estranee
Solo a questa età: 3-4 anni, essendo il piccolo più maturo e forte, avrà la possibilità di ben relazionarsi con il gruppo dei pari e con gli adulti con i quali non si è ancora instaurato un rapporto di piena fiducia e legame affettivo. Non è certamente fisiologico e non aiuta il sano sviluppo psicologico, affettivo ed emotivo del bambino ciò che avviene attualmente in Italia, dove i piccoli frequentano la scuola dell’infanzia dalle 6 alle 8 ore al giorno.

Il bisogno di avere accanto a sé le figure fondamentali della sua realtà interiore: i genitori, con la figura materna in primo piano, nasce da elementi istintivi primordiali simili a quelli di molti altri animali che, inizialmente, vedono solo la madre o i genitori, come fonte di sicurezza, fiducia, amore, protezione, mentre gli estranei e i luoghi sconosciuti sono avvertiti come fonte di pericolo, rischio e abbandono.
Per tale motivo quando un bambino piccolo è costretto a cambiare per qualche tempo persona di riferimento, questa situazione è vissuta come una dolorosa forzatura, giacché le persone con cui non vi è un profondo e duraturo legame affettivo sono da lui avvertite come pericolosi estranei, sia che si tratti d’adulti come le baby-sitter o le insegnanti dell’asilo nido, sia che si tratti di bambini sconosciuti con i quali non è capace e pronto ad interagire e dialogare.
I doveri della politica e delle istituzioni pubbliche
In definitiva, se le istituzioni pubbliche desiderano che un bambino cresca serenamente ed in modo equilibrato, dovrebbero permettere che accanto ad ogni bambino che nasce vi sia, fino ai tre-quattro anni, la presenza di almeno uno dei genitori che abbia il fondamentale compito di seguire costantemente e in modo attivo, i bisogni e le necessità affettive ed emotive del minore.
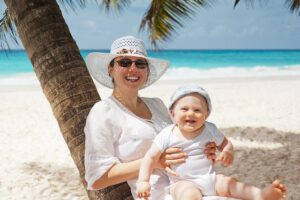
Altre fonti di sicurezza
- Poiché il bambino, ma anche i piccoli degli altri animali, sono esseri abitudinari, essi avvertono tranquillità, fiducia e senso di sicurezza, quando attorno a loro gli avvenimenti si svolgono sempre nel medesimo modo. I cambiamenti, specie se repentini e non adeguatamente preparati, li mettono in ansia e li caricano di paure.
- Sensazione di sicurezza egli avverte quando il proprio ambiente familiare è stabile e non vi sono nuove presenze che si inseriscono nella sua vita: come nuove fidanzate e nuovi fidanzati di papà e mamma, nuovi fratellastri e sorellastre, nuovi nonni.
- Contribuiscono alla sicurezza del bambino la coerenza e la linearità dei comportamenti degli adulti. Egli si sente sicuro quando i genitori usano tra di loro e con lui parole ferme e decise, ma con un tono molto sereno, affettuoso, ricco di ascolto e di dialogo.
- Il bambino prova un senso di sicurezza quando nota che mamma e papà sanno affrontare i problemi, gli ostacoli e le vicissitudini quotidiane con fermezza e tranquillità.
- Notevole sicurezza il bambino avverte quando tra i genitori vi è un buon accordo e una buona armonia e che il loro legame è solido e stabile (Tribulato E.).
- Poiché il bambino ha bisogno di sentirsi accettato ed amato dai suoi familiari, fonte di sicurezza è il poter dire in ogni momento: ‹‹Io sono un figlio buono e sono importante per papà e mamma. Loro sono contenti e orgogliosi di me, di quello che io sono, di quello che io faccio, di come mi comporto››.
- Anche l’ambiente fisico è importante. È fonte di sicurezza l’ambiente domestico, mentre un luogo estraneo, o diverso, istintivamente è avvertito come minaccioso e rischioso; e pertanto infonde paura ed insicurezza.
Infine, ma non ultimo, fonte di sicurezza è avvertire nei propri genitori un sufficiente equilibrio e una intensa forza interiore.
[1] Militerni R. (2004), Neuropsichiatria infantile, Napoli, Idelson Gnocchi, p.97.


